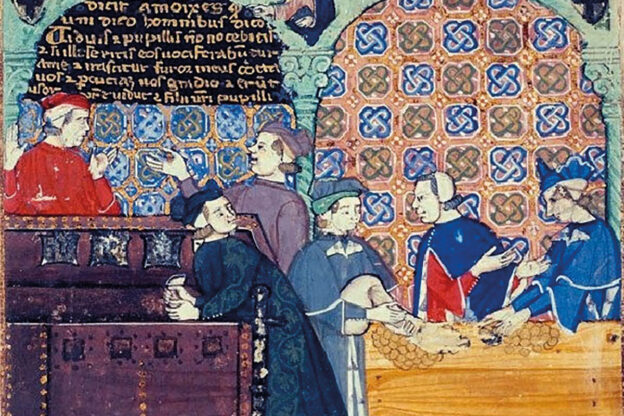Come ha ricordato Manuela Furnari nel suo saggio “Quando correva il novecento”, contenuto nell’edizione Feltrinellidi Razmataz, Italo Calvino scriveva che l’idea che prende forma nei romanzi del ‘900 è quella del romanzo dentro cui si possono tracciare molteplici percorsi, un’enciclopedia aperta. Razmataz è infatti una “grande opera aperta”, rete di nomi che rimandano ad altri nomi, storie che riportano ad altre storie, altre suggestioni.
In qualche modo somiglia a tutti noi perché, se ci pensiamo, la nostra vita non è che una biblioteca di libri che rimandano ad altri libri e che aprono finestre su racconti e mondi possibili. Quel che è certo è che “quest’opera d’arte varia” somiglia al suo autore, al maestro Paolo Conte che, come l’arte sfugge alle definizioni strette per non farsi imbrigliare, proprio come i cavalli che dipinge, protesi nella corsa e che io immagino selvaggi.
Hemingway ha immortalato la Parigi eletta degli anni ‘20 con la frase: “Se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dopo, ovunque tu sia, essa ti accompagna perché Parigi è una festa mobile” ed è proprio là che siamo andati idealmente venerdì scorso a Passepartout.
Un viaggio, questa volta non a bordo di una Topolino amaranto, ma su un treno rosso da cui siamo scesi tutti a Parigi. Tutti armonicamente divisi tra un altrove ideale e il qui e ora della nostra biblioteca.
Anche Paolo Conte mi è sembrato “nostro” quella sera, stretto dall’abbraccio della sua città e restituendo quell’abbraccio con là generosità del “darsi” che solo i grandi artisti possiedono e che ha fatto sì che fosse un incontro più che un evento.
È stato un intrigo di atmosfere e sensazioni che hanno il ritmo della sua musica che da sempre ha una doppia capacità: portarci in un altrove possibile o descrivere noi e i nostri paesaggi con note e frasi folgoranti, che ci raccontano. Lontano e vicino in un ritmo coinvolgente.
Il mio ruolo è quello di fare domande e spesso devo contrattare con l’emozione, scendere a patti con lei perché resti nella sua giusta misura.
Non so se nell’intervista con Paolo Conte e Manuela Furnari abbia vinto lei oppure io.
Il giornalismo in questo caso è sempre opportunità e rischio. Rischio che in pochi minuti possa andare in frantumi l’idea, tutta personale e chiaramente infondata, che negli anni hai costruito di un artista che fa parte della tua quotidianità.
Non è accaduto e gli sono grata.
Il raffinato poeta e artista, che al lusso ha sempre preferito lo stile, resistendo alle seducenti sirene della fama e dell’ego, lo stesso che non ha mai desiderato vivere altrove perché, in fondo, “ La maggior parte degli scrittori viene dalla provincia, qui c’è più teatralità e i caratteri dei personaggi sono più definiti”, non si è smentito.
La sensazione di essere seduta accanto a “tutto un complesso di cose”, meraviglioso scrigno di creatività, è stata ancora più forte quando i ragazzi di Passepartout gli hanno chiesto se avesse nuovi progetti.
Ha risposto che al momento non avverte quell’esigenza di musica assoluta che lo porta a scrivere.
La risposta immediata di uno dei ragazzi: “maestro, allora scriva per noi”.
Gli ero accanto. A quella richiesta gli ho visto mutare espressione, come percorso da un moto d’entusiasmo.
È questa reciprocità tra il pubblico e l’artista la sensazione più viva che personalmente mi resta della serata con Paolo Conte. E a chi mi chiede com’è andata, non posso che rispondere: “È stato un sogno fortissimo”.
Alessia Conti